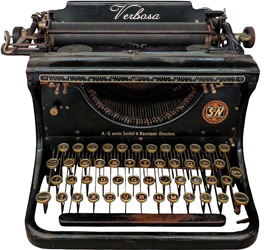Li ritrovo, passo dopo passo, mentre, nelle fresche mattinate d’estate, vado alla ricerca di un benessere fisico. Li ricompongo con pazienza certosina, un pezzetto alla volta, che si incastra con tutti gli altri, fino a completare il puzzle dei ricordi della mia infanzia.
Ho percorso quella strada migliaia di volte, pigiando il piede sull’acceleratore per la fretta di andare. Solo sguardi veloci e distratti, col pensiero rivolto altrove. Ora è diverso. La camminata, pur se veloce, perché se no non serve secondo il mantra dei nutrizionisti, mi spinge a guardarmi intorno, non solo avanti.
E mentre cammino a passo svelto, la osservo -ogni mattina- due volte, all’andata ed al ritorno.
E’ la casa in cui sono nata. Un casello ferroviario, con un numero identificativo: 114, che sta ad indicare i km della tratta. Oggi i muri sono pressocché nascosti alla vista, avvinti, in un abbraccio, dall’edera, come in quella canzone di Nilla Pizzi, che fa pensare a legami indissolubili.
La struttura è da tempo abbandonata, anche se altri l’hanno abitata dopo il 1960, quando ci siamo trasferiti nella nuova casa in via Puglia. Andata in decadenza e poi ristrutturata, ha conservato tuttavia l’impianto originario di queste costruzioni, volute dalle Ferrovie come alloggio del personale, responsabile della manutenzione e del controllo della linea.
In questo edificio a due piani, con due stanze al piano terra e due al primo piano, separate da una scala al centro, ho vissuto i miei primi cinque anni di vita, insieme ai miei genitori, due sorelle ed un fratello, tutti più grandi di me.
Lo stridere dei freni e lo sferragliare ritmico del metallo sulle rotaie hanno cullato i miei sogni di bambina. La vitalità del movimento, le attese tra un treno e l’altro, la voglia di andare verso mondi da esplorare hanno accompagnato la mia infanzia.
Sono cresciuta con i fischi nelle orecchie, dapprima fiochi in lontananza, poi più penetranti tanto da percuotere i miei timpani e scuotere i muri, fino a spegnersi, mentre i treni in transito si allontanavano in fretta.
I binari così perfettamente paralleli, con le traversine di legno allineate come fachiri sdraiati su un letto di ghiaia, si perdevano in un orizzonte infinito fin quasi a toccarsi; pericolosi eppure invitanti come scale sdraiate a terra, sono stati il mio primo mondo da esplorare, il mio primigenio spazio vitale. Pericolosi ed insieme affascinanti, ma anche ossessivi per i vetri che facevano tremare al passaggio dei convogli, nonché per il batticuore ed il fiato sospeso che mi causavano.
Come ha scritto non ricordo chi, nulla appartiene al mondo delle meraviglie come il treno. Tutti i bambini ne sono attratti, tutti vogliono salirci sopra e viaggiare.
La mia ferrovia mi è rimasta dentro e non poteva che essere così!
Giorno dopo giorno ha scandito, in intervalli ritmati, la vita quotidiana della mia famiglia, che viveva ai confini della realtà, in un’epoca dove erano abissali i solchi socio-economici, dove si viveva la fatica del lavoro, del massacrante quotidiano, dell’esistenza lenta e monotona, dove si rincorreva il progresso, che appariva sempre più a portata di mano, come quel treno che sfrecciava a due passi da me. Quel treno che mi sollevava, col suo repentino anomalo vento, le succinte vesti arricciate di bambina e mi scompigliava i riccioli biondi, mi faceva desiderare e quasi assaporare il senso del viaggiare pur restando ferma lì, davanti casa.
Per me, la ferrovia non è stata metafora di marginalità, ma simbiosi, unione, spinta ad andare oltre, voglia di attraversare quei binari solitari per andare alla scoperta del mondo che c’era più in là. Perché a 114 i giorni si rincorrevano tutti uguali, tra una mamma che conciliava le faccende di casa con la cura di marito e figli, con un papà, a capo di una squadra di manutenzione di una tratta di binari, che usciva la mattina presto e tornava a pomeriggio inoltrato, due sorelle troppo grandi che si prendevano cura di me più che giocare con me, un fratello con il quale dividere il tempo dei giochi e della spensieratezza.
Una vita racchiusa in una realtà limitata, dove i contatti sociali erano davvero pochi. Un ponte sul ruscello segnava il confine tra due territori diversi; al di là qualche casa sparsa, al di qua nulla oltre la strada. E quel lungo rettilineo da attraversare rigorosamente a piedi era il pegno da pagare quotidianamente per raggiungere il centro abitato e dunque, la scuola. Io no, ero ancora troppo piccola, ma Ada e Giovanna e Tonino, cartella in spalla, avevano l’onere di percorrerla almeno due volte al giorno. Altri tempi, dove la fatica del vivere cominciava presto e bisognava andare comunque e dovunque, superando, a spese proprie, paure ed ostacoli. Ci si temprava presto nel corpo e nel carattere, oppure più semplicemente quelle paure te le sei portate dentro. Ben riposte e nascoste, sono diventate adulte con il trascorrere degli anni, inibendo il tuo essere bambina o adolescente e facendoti crescere alla svelta, tuo malgrado.
Era una società spartana, senza fronzoli, dove il niente che possedevi ti costringeva ad immaginarti ed inventarti il tutto. La cucina al piano terra a sinistra era modesta, accoglieva solo il necessario. Il camino era il punto di ritrovo della famiglia, soprattutto la sera. Accanto al fuoco, che andava alimentato senza tregua, spesso troneggiava la pignata coi fagioli, ma anche solo con l’acqua, che si poteva avere calda per ogni evenienza. A destra c’era la sala da pranzo: il tavolo in legno che si allungava con delle prolunghe quando c’erano altri familiari, era opera di mio padre che, prima di diventare ferroviere,aveva imparato il mestiere di falegname presso un artigiano del suo paese, Molinara. Anche la camera da letto era stata realizzata da lui: la testata, i comodini ed il comò con le maniglie d’osso color avorio, l’armadio ad una sola anta nella quale ci si poteva specchiare ed un cassetto in basso. Nella camera accanto, dormivamo noi figli, in un letto matrimoniale ed un lettino, l’essenziale!
Il bagno aveva il lavandino ed il water, ma non c’era l’acqua corrente. Però dalla finestrella, alla quale mi potevo affacciare solo stando in punta di piedi, si poteva osservare il fiume Calore, quello che spaventava i più grandi quando le forti piogge ne facevano aumentare il livello. Non siamo mai stati inondati, ma le mie sorelle raccontano di quanto fossero immense le loro paure in quei giorni!
L’acqua era disponibile in una cisterna, che probabilmente raccoglieva quella piovana. La tiravano su con una pompa a mano per gli usi domestici, ma quella per bere si andava a prendere al ruscello Reventa, poco distante. Era compito prevalente delle mie due sorelle che , munite di cecini di terracotta, quelli a due manici, che usavano i contadini per dissetarsi nelle calure estive durante il duro lavoro dei campi, coglievano l’occasione per distrarsi un po’ e stare da sole in libertà.
Attraversata la strada provinciale, si inoltravano per una stradina in discesa per circa 200 metri fino a raggiungere la fontana. Il sentiero, spesso, nascondeva ospiti sgraditi alla vista di due fanciulle che si spaventavano facilmente, soprattutto se avevano sentito storie di streghe, fattucchiere e janare davanti al fuoco e, quando questi ultimi ardivano mostrarsi, erano fughe repentine, gambe in spalla. Poteva così accadere che i due cecini si scontrassero incidentalmente e rovinassero in mille pezzi sul terreno. Rientrare in quelle condizioni significava ricevere un certissimo rimbrotto da parte di mamma, magari anche condito da una tiratina di capelli e, di sicuro, qualche pesante scapaccione da parte di papà, come punizione esemplare per non essere state disciplinate e responsabili. In quegli anni nessuno si scandalizzava più di tanto dell’uso di maniere forti, come quando, ai miei primi tentativi di scrivere con la mano sinistra, pensò bene di legarmi la mano mancina alla sedia per costringermi a scrivere-riuscendovi- con la destra.
Non avevamo ancora l’energia elettrica: al calar del buio si illuminava la casa con la lampada ad acetilene, quella usata dai ferrovieri per invitare a salire in carrozza, con l’impugnatura di legno mobile, che si faceva roteare per produrre più luce. Quando si riusciva ad accendere, però! Il più delle volte si sentivano solo le imprecazioni di mio padre e, un paio di volte, l’abbiamo vista prendere il volo ed atterrare sui binari, morta stecchita.
La sera, dopo cena, non c’era altro da fare se non andare a letto. E, per chi non aveva sonno, visto che si dormiva tutti insieme in una stanza, cominciavano, ma sottovoce per non svegliare i grandi e non essere sgridati, scherzi e racconti segreti, risatine e battute, fino a che, uno alla volta, si cadeva tra le braccia di Morfeo. Al mattino presto, ci svegliava il rombo della Lambretta Innocenti con cui papà si recava al lavoro. Un mezzo di locomozione dove tutto era in bella vista, ben esposto; papà, col suo fare didascalico ci raccontava che consumava poco, non superava i 70 km orari e, come amava ripetere spesso, era costata tanti sacrifici, perché c’erano voluti oltre sei mesi di stipendio per comprarla. Era bello salirci sopra tutti e sei per andare a trovare i nonni a Campo d’Antuono. Papà alla guida, mamma seduta da amazzone dietro e tra di loro mio fratello. Sui predellini laterali le due sorelle maggiori e io in piedi dietro allo sterzo, protetta dalle forti braccia di papà. Il tratto era breve, per fortuna, e non si pensava affatto ai pericoli che un tale carico potesse provocare, anche perché di mezzi di trasporto ne viaggiavano proprio pochi, allora, sulle strade. Il 1960 è stato l’anno del trasferimento nella nuova casa in via Puglia, progettata da zio Alfredo, l’unico fratello di mia madre che aveva studiato da geometra e costruita sul terreno di sua proprietà. …..(continua)