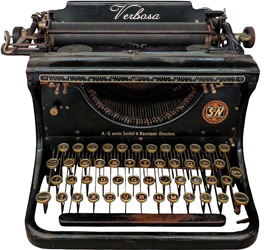Eccole, sono finalmente mature, pronte all’uso. Ogni fine giugno è così: un rito che conserva la sua sacralità, una sequenza ricorrente di gesti codificati dalla natura che regala frutti, un desiderio recondito che sento riaffiorare con prepotenza dal passato.
Ero poco più che bambina ma non ancora adolescente e vivevo da un po’ nella nuova casa in via Puglia dai molti comfort rispetto all’abitazione precedente e molto più vicina al paese. Mio padre, tra tante altre, nutriva la passione per alberi di ogni specie: ne piantava a iosa, in particolare per disporre di frutti maturi in ogni stagione dell’anno. Erano tempi ancora bui quegli anni sessanta per il nostro bilancio familiare perchè la costruzione della nuova casa aveva assorbito buona parte dei risparmi, ma non ci è mai mancato il necessario. Frutta e verdura andavamo ad acquistarle al mercato che si teneva di fronte alla stazione ferroviaria di Ponte-Casalduni il venerdi di ogni settimana, ma si cercava di essere autosufficienti se si aveva a disposizione un po’ di terreno. Noi ne avevamo in abbondanza. Il pero, giusto al centro del vialetto di accesso alla casa, produceva ombra benefica ai mezzi in sosta e, nel periodo giusto, regalava frutti succosi e dolcissimi, da assaporare cogliendoli direttamente dall’albero. Ma, si sa, gli alberi hanno bisogno di essere scalati se non sono più giovincelli dal fusto flessibile. E mio padre, a cui fumava sovente il cervello come inventore di attrezzi che oggi sono reperibilissimi sul mercato ma allora no, aveva legato ad una canna lunghissima un barattolo usato di latta -quello della carne simmenthal, per capirci!- a cui aveva praticato un taglio affilato, per ingabbiare la pera e staccarla dal ramo, senza il bisogno di una scala. “Perilli” venivano identificati da tutti per il loro essere di taglia piccola, con la buccia verde, che diventava un po’ giallastra quando maturavano al punto giusto.
Accanto alla porta d’ingresso secondaria, quella più usata, che portava al giardino dalla cucina, sulla sinistra c’era un’aiuola rettangolare fatta di tufo che correva lungo tutto quel lato della casa. Qui convivevano beatamente fiori stagionali, passione del bello, cara a mia madre, con alberi da frutto, passione del buono, cara a mio padre, che aveva individuato e scelto come posto ideale per le albicocche e vi aveva piantato due alberi che regalavano minuscoli frutti deliziosi nella calda stagione. Più avanti, verso il garage, si allungava su una tettoia nata dalle sue mani modellando materiale riciclato (traversine e pali di legno e in ferro) una pergola di profumatissima uva fragola, proprio vicina ad un’altalena costruita con ferro di recupero. Più in là, aveva piantato una vigna che accompagnava le pendici del terreno verso la strada, dove si potevano trovare svariate qualità di uve da tavola, sia bianche che rosse, e -tra i filari- piante di pesche, di fichi, di mele, di pere e poi…. lei, l’amarena.
Troneggiava al sole, nella sua elegante rotondità. In primavera la osservavo stupita schiudere boccioli delicati di un colore bianco candido, che si aprivano al primo sole di marzo per coprirsi, subito dopo, di tenere foglioline verde chiaro ed infine vedevo comparire come d’incanto frutti minuti, legati a coppie, che colorivano piano piano grazie al caldo sole di giugno fino a raggiungere la lucida tonalità simil-sangue. Erano pronte per essere colte, ma non mangiate. Le amarene non possono essere gustate così come sono; occorre trasformarle con il lavoro. Tanto lavoro! Allora, quando vedevo il cesto pieno, cominciavo a sudare! Tutta la famiglia era chiamata a raccolta intorno al tavolo rotondo di cemento, sotto il fresco bursò. Adeguatamente vestite di abiti vecchi, il rito poteva cominciare: bisognava togliere delicatamente il nocciolo, senza ridurre a poltiglia la polpa. Bisognava averne cura e conservarne la forma. Naturalmente tutto avveniva sotto la vigilanza attenta delle mie due sorelle maggiori, incaricate da mia madre di tenere a bada me e mio fratello, che gironzolava attorno più come osservatore che come aiutante. Si sa, la manualità è una dote al femminile, ma capitava di frequente che partissero schizzi di succo e così, col passare del tempo, diventavamo tanti dracula in gonnella. Succedeva anche che si ingaggiasse una vera e propria sfida tra me e mio fratello, che rispondeva in malo modo ai miei schizzi provocatori, che veniva prontamente interrotta dalla richiesta di aiuto invocata a pieni polmoni dal malcapitato e dall’arrivo immediato di nostra madre che ci rimetteva in riga. Ma il momento bello di questa faticosa esperienza era uno solo: lo sversamento dello zucchero nella zuppiera bianca bombata della Richard Ginori made in italy era una vera goduria per la vista ed il palato. Osservavo la massa bianca cadere a pioggia sul composto, perdersi affogando nel succo come d’incanto per diventare un tutt’uno. Il cucchiaio di legno faceva il resto. Io ero lì pronta ad affondare l’indice per assaggiare l’invitante glassa rossa, ma mia madre, piè veloce, simulando un gesto a ‘mo di scappellotto sulle mani, mi sottraeva alla vista la zuppiera, ricoprendola prontamente con un canovaccio a rete che sembrava più un velo da sposa e la portava al sole. Al calar della sera, non bisognava dimenticare di ripararla in casa e il mattino dopo riportarla ancora in luogo soleggiato. Ogni tanto bisognava ricordarsi di rigirarle bene con il cucchiaio di legno per agevolare l’azione del sole. Non appena tutto lo zucchero si era trasformato in sciroppo, il che avveniva in circa 7/10 giorni, si sterilizzavano i vasetti di vetro per essere riempiti. Da questa operazione io ero esonerata, perché il prezioso composto non poteva essere affidato a mani insicure e maldestre di bambina.
Il rito si concludeva con il posizionamento dei barattoli nella dispensa, non proprio sottochiave ma con divieto di utilizzo senza il benestare di mia madre, che decideva in proprio quando consumarle. E comunque si trattava di occasioni importanti: feste oppure visite di parenti ed amici. La prelibatezza veniva servita in bicchierini di vetro trasparenti, piccoli quanto bastava a non sprecarne troppe, con il rischio di finirle troppo in fretta.
E quando, infine, si affondava il cucchiaio nel barattolo senza pescarne più, lo sciroppo diventava subito disponibile per tutti noi. Diluito con acqua- e ghiaccio in estate- diventava una bibita gradevole e dissetante.
Il rito si è concluso anche quest’anno. Le amarene non sono più quelle, ora posseggo il mio albero, che dà frutti. La bambina di ieri oggi è una donna più che adulta, diventata unica artefice della prelibatezza, realizzata ancora con le stesse modalità di allora. Non occorrono più autorizzazioni per gustarle. Custode della bellezza delle emozioni vissute, sono qui a tramandarle con i nuovi mezzi disponibili a chi sa apprezzare ancora i ricordi e la delizia dell’incanto.