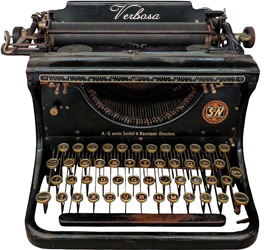Girovagando nella rete, mi imbatto in un video su Facebook che attrae la mia attenzione. Quando si tratta di bambini, non resisto. Il filmato presenta loro un apparecchio davanti al quale è forte la sorpresa mista a smarrimento, mentre una voce femminile fuori campo pone domande.
Cos’è quell’apparecchio sconosciuto? Titubante qualcuno risponde:- Un telefono di una volta!– Qualcun altro, recuperando storie già vissute:- Io l’ho visto qualche volta in film vecchi!–
Si tratta, l’avrete certo intuito, del telefono dei nostri genitori (per chi poteva permetterselo!), col filo penzolante da una cornetta pesantissima, lucido e corvino, con il disco rotante per formare il numero da chiamare.
Com’è? –E’ complicato! Bello!-rispondono. Uno di loro mette il dito in uno dei cerchietti, pensando che sia sufficiente a comporre il numero: non avendolo mai usato, non intuisce che deve girare il ditino fino alla fine e ripetere l’operazione più volte; un altro cade dalle nuvole quando la voce gli chiede di prendere cornetta. Cosa sarà mai?
Immersi nella rete e ormai profondamente dipendenti dal cellulare, dal tablet, dai video-giochi, non possono sapere- i Millennians- che è esistito un apparecchio legato indissolubilmente da un filo alla presa, come un cagnolino al guinzaglio e addirittura uno financo attaccato alla parete di casa.
Esilaranti le loro risposte:
–Ingombrante da portare in giro, difficile da usare, si devono ricordare i numeri a memoria, non si possono mandare messaggi-.
E se, durante la visione, sei attratto dallo stupore evidente suscitato da un apparecchio a noi familiare ed amico, alla fine ti fermi a pensare che il mondo attuale è lontano anni-luce dal tuo!
Il telefono fisso non è solo un vecchio ricordo di un passato recente; per noi -generazione sessantottina- è molto di più. Con passo felpato, insieme a radio e Tv, ci ha introdotto nella comunicazione virtuale, anche se oggi le sue funzioni appaiono quasi risibili. Ricordo bene l’uso moderato che se ne doveva fare, quando il mio papà ha stipulato il primo contratto di abbonamento poco dopo il 1960, nella nuova casa da poco abitata. Conversazioni solo all’occorrenza e soprattutto telegrafiche, se no quando arrivavano le bollette erano guai.
Ho vissuto sulla mia pelle il conflitto generazionale, quando, dopo le lezioni ricevute in famiglia sull’uso appropriato di questo apparecchio, ho dovuto affrontare un nuovo paradigma con i miei figli appena adolescenti. Assistevo a continue discussioni tra i due per accaparrarsi l’unico apparecchio disponibile e li affrontavo con piglio minaccioso, quando vicendevolmente si chiudevano nelle proprie camere e, con la cornetta all’orecchio, trascorrevano ore interminabili a relazionarsi con amici o fidanzatine di turno, incuranti dei miei inutili rimbrotti sui costi altissimi delle chiamate. Nessun passo in avanti neanche quando dotammo quasi ogni stanza del cordless, perché capitava sempre più spesso che, alzando la cornetta, trovavi l’unica linea disponibile già occupata ed anche allora giù minacce di fare presto e liberare la linea perché c’erano delle priorità da rispettare. Troppi gli avvisi di chiamata rimasti inevasi!
In quegli anni, chiunque uscisse di casa, doveva dire con precisione quello che avrebbe fatto e quando sarebbe tornato per non destare eccessiva preoccupazione negli altri familiari. Se avevi un problema, dovevi preoccuparti di trovare una cabina telefonica o un telefono a gettone per avvisare.
Poi c’è stato il punto di svolta: l’avvento del telefono cellulare che, entrando prepotentemente nelle nostre vite, ha cominciato a controllarle senza pietà, ma soprattutto a modificarne rapporti ed assetti spazio-temporali.
Il telefono con il filo stabiliva interazione umana tra due persone, annullando le distanze, solo al verificarsi di alcune pre-condizioni: il trovarsi nello stesso posto del telefono che squillava, il desiderio di rispondere alla chiamata, la curiosità di sapere chi ci stava cercando e perché.
Riusciva ad avvicinare due interlocutori che volevano condividere un’informazione, una notizia, un colloquio, un’esperienza, annullando i limiti di una distanza fisica.
Oggi il telefonino rende disponibile in ogni luogo e in qualsiasi momento l’accesso al nostro capitale sociale-relazionale ed al contatto, secondo il paradigma dell’ always on, ossia l’essere sempre connessi.
Smartphone sempre con noi ci regalano un tempo senza diluizione, un eterno presente, che annulla l’attesa e rinvia il futuro, dando vita ad assetti mentali ed identità meno definite.
Una reperibilità continua è divenuta strumento di controllo, di rassicurazione, persino di ricatto: –Lascia acceso il cellulare, così sto più tranquilla!-
Il telefonino è la nostra prolunga, quel ponte che ci collega con chi è lontano e, nello stesso tempo, ci allontana da chi è vicino. In ogni luogo, la conversazione è sempre intermittente, sembra impossibile chiacchierare senza interruzioni perché raramente si spegne l’apparecchio, così come è normale pranzare tra una chat ed un sms, tra una chiamata ed un whatsapp. L’oggetto è sempre con noi, con la voce, con i messaggi, con l’immagine fotografica, con i selfie, con la ripresa filmata. Una presenza assidua e costante di un terzo incomodo, sempre pronto ad azzerare l’attesa, fornendo risposte a qualsiasi dubbio, per vivere l’immediatezza del momento.
Reale e virtuale si mescolano perfettamente tanto da riuscire ad oscurare persino il concetto di comunità: ognuno diventa un pianeta a sé che cerca contatti asettici più per via telematica che per incontri vis-a-vis.
In questo ininterrotto gioco di ruolo, c’è spazio per tutto, ma non per la solitudine costruttiva, quella che ci obbliga a fermarci a pensare, a riflettere sull’esperienza, lontani dagli altri, per cercare significati e risposte, punti di equilibrio tra individuale e collettivo, tra la dimensione pubblica e quella privata dell’esistenza, per provare ad interrogarci sulla nostra identità, quella linea di confine che separa l’io dagli altri, che dovrebbe essere chiara e netta, ma anche il nostro limite, la nostra fonte potenziale di frustrazione. Senza l’identità non potremmo riconoscerci come diversi dagli altri e solo grazie ad essa raggiungiamo la sicurezza di una stabilità emotiva capace di durare, a condizione che si rinunci all’illusione di ubiquità, quella facoltà di essere presenti sempre e contemporaneamente in più luoghi diversi. La rivoluzione telematica sembra aver conferito, di fatto, anche all’essere umano quella che storicamente è stata prerogativa di Dio e di qualche santo. Ma non è così. Il carattere ubiquo è imprescindibile dall’onniscienza e dall’onnipotenza divina e noi che non siamo Dio né santi, viviamo nell’illusione di dominare la realtà esterna e nelle lusinghe di un vero e proprio «sentimento di onnipotenza».
In questo gioco di relazioni con noi stessi e col mondo, mentre il cellulare ci appare come una protesi che ci lega indissolubilmente agli altri individui, scopriamo a nostre spese che non può assolvere in alcun modo alla funzione di salvarci dall’angoscia da isolamento e da solitudine!
Qui non si vuole negare l’utilità di un apparecchio che è al contempo macchina fotografica, videocamera, radio, telefono, display per sms e per navigare sul web, tuttavia è altrettanto evidente che ciascun” portatore malato di telefonino” presenti gravi inadempienze sulla concentrazione, sulla “presenza” nel momento che sta vivendo, sulla consapevolezza di sé, sulla memoria e persino sulla vita affettiva, periodicamente falsata d un soggetto terzo di sicuro troppo invadente.
Dovremmo diventare consapevolmente dei portatori sani di tecnologia, capaci di utilizzarla al meglio per non essere pervicacemente usati dalla stessa.