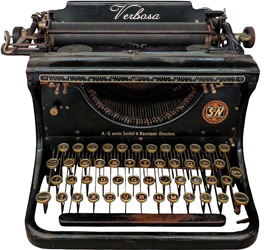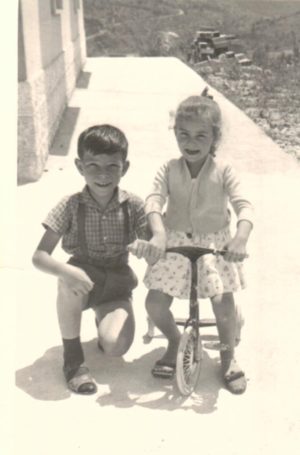Maria De Biase è una preside che ho conosciuto grazie ai social e per essere stata protagonista di una puntata della trasmissione televisiva di Domenico Iannaccone su Raitre a giugno scorso. Ho scoperto così che, nel cuore del Cilento, da anni promuove il rispetto della natura, l’ecosostenibilità ed il riciclo con azioni concrete, innescando un reale cambiamento di rotta nella scuola che dirige, racchiuso nel motto: “Io sono la speranza dell’improbabile”, che ben riassume il suo quotidiano impegno ecologico, etico e didattico. Altro che tassa sulle merendine per finanziare la scuola! Nella “sua” scuola plastica e merendine preconfezionate sono bandite, si fa merenda con pane ed olio/ pane e marmellata, il tutto offerto gratuitamente dalle aziende del territorio. Non solo. Gli alunni hanno imparato anche le tecniche giuste per realizzare saponette con gli oli esausti. Si tratta di semplici gesti, che reiterati quotidianamente, diventano stili di vita, attraverso i quali “quei 600” bambini, insieme alle rispettive famiglie, riscoprono ogni giorno quanto sia possibile e bellissimo preservare con pochi gesti il Pianeta che ci ospita e come spesso noi adulti, distratti da tante altre faccende che riteniamo più importanti, ci dimentichiamo di porre in essere.
Il pensiero corre a tutta la mia esperienza pregressa -di bambina, di adolescente, di donna, di mamma, di docente, di dirigente, di pensionata -che ha attraversato, con identica sobrietà di pensieri ed azioni, il tempo del riciclo e del riuso, dello spreco e dell’abbondanza, del troppo che dura poco, dell’agire presto per non estinguersi.
E così, il pensiero va a ritroso, al mio tempo scolastico. Cerco di recuperare pezzi di vita, scavando nel passato, per svolgere uno dei tanti compiti di realtà (la tipica “ricerca” di ieri) che alunni di oggi si vedono assegnato per casa:
Su, bambini, oggi dovete parlare del cibo che mangiate. Intervistate la famiglia per ricevere informazioni da dove proviene, come viene coltivato e come arriva sulla vostra tavola.
Mi metto alla prova, ripensando ad allora e provo a svolgerlo. Mi autorizzo qualche divagazione di troppo, che spero non venga sottolineata con la matita rossa, premettendo che non sarebbe stato un compito difficile per me, anzi mi sarei fregata le mani. Avrei dovuto faticare davvero poco, sapendo di essere parte attiva di quella ricerca, con l’emozione dell’esserci e la fatica del fare perché noi l’orto- a casa- ce l’avevamo davvero e io ero lì, sempre, quando c’era da fare. Dunque, sarebbe bastato trasformare la pratica in teoria con una forma di scrittura corretta e chiara e….voilà!
Eravamo alla fine degli anni sessanta del secolo scorso ed allora era normale coltivare l’orto per chi, come me, viveva in una casa di periferia ed aveva del terreno a disposizione. Certo, costava molto in termini di impegno e il lavoro fisico lasciava tracce sulle mani, accarezzate da rughe e duroni, sulla fronte dove il sudore scorreva come resina dai pini, sulle schiene piegate come i profili addolciti delle nostre colline e sempre doloranti a fine giornata. Eravamo calciatori pronti a vincere la partita sul campo, pronti a fornire il nostro personale contributo al gioco di squadra. E non si accettavano scuse o repliche del tipo:- Devo fare i compiti!– Tutto il resto passava in second’ordine: –Puoi studiare dopo aver finito!-
Avevamo imparato- a nostre spese- che si trattava di un rito da compiere, secondo compiti propri di ogni componente della famiglia, assegnati quasi senza parlare, da accettare senza batter ciglio. Piantare, zappettare, irrigare, cogliere, selezionare erano verbi che conoscevamo alla perfezione nella vita quotidiana. In piena estate vivevamo i giorni delle conserve. Bottiglie di birra e “boccacci”(come dialettalmente chiamavamo i barattoli di vetro) da lavare all’aperto in grandi conche e poi riporre a testa in giù nelle ceste di canne intrecciate coi manici, utili accessori per essere trasportate; i pomodori San Marzano da selezionare accuratamente, in cestelli di canne a strisce gialle e marroni, per perdere l’acqua in eccesso, dopo essere stati lavati nella grande vasca esterna in grigio cemento precompresso, posizionata accanto al bursò di edera. La “caudara” di rame ben avvolta dal suo fusto di ferro adattato allo scopo da mio padre con tagli a misura, andava riempita di acqua che, giunta ad ebollizione, accoglieva un cestino di canne intrecciate in cui venivano riposte poco alla volta i pomodori. Bisognava calarli ed alzarli più volte e rapidamente nell’acqua bollente, ma questa operazione mi era preclusa perché abbastanza pericolosa. Io attendevo poco più in là, pronta a pelare i pomodori che ancora bollenti venivano scodellati sul tavolino di legno, quello che mia madre usava di solito per fare la pasta in casa. Le mie mani acerbe li accoglievano mal volentieri: li facevo rigirare alternativamente soffiandoci su per disperdere calore. Ma era grande il piacere che provavo mentre li spogliavo della pelle lucida e ne vedevo emergere la polpa rossastra e vellutata! Le mie sorelle provvedevano a tagliarli in due e ad eliminare i semi acquosi raccolti in scodelle di latta bianca con i manici. Mia madre osservava il lavoro di ciascuno, mentre faceva la spola tra il fuoco, alimentato da mio padre e da mio fratello, e la postazione di lavoro. Quando comparivano i “boccacci” e una cesta di basilico lavato ed asciugato alla bell’e meglio, il secondo rituale poteva avere inizio: una foglia di basilico sul fondo e via con le pacche di pomodoro pelato! Ogni tanto il barattolo doveva essere capovolto per eliminare il liquido in eccesso, un’altra foglia di basilico e via fino al bordo superiore, che doveva essere pulito perfettamente prima di essere chiuso dal coperchio. Restavano in fila così, in attesa che iniziasse la battaglia della bollitura, coricati tra stracci vecchi, a mo’ di protezione, nella caudara. E quando il fuoco veniva spento, lasciandoli in ammollo, il giorno dopo, non senza timore, mia madre li sottoponeva ad attenta ricognizione prima di riporli! Naturalmente in quei giorni, c’era poco tempo per cucinare ed allora si utilizzava il pomodoro già quasi pronto per uno spaghetto veloce. Ma il pensiero va alle spighe di mais abbrustolito sulla brace, che emanavano un profumo unico, che persiste come un ancestrale ricordo di quei giorni faticosi ma spensierati e carichi di speranze.
Alla stregua dell’odore acre dell’uva delle vigne che diventava vino, della profumata frutta matura che si trasformava in marmellata o liquore, della verdura resa asprigna dall’aceto di cottura che finiva sottolio, delle olive messe a dormire in salamoia dentro damigiane di acqua e sale, delle noci dal mallo verdeggiante, raccolte nella ricorrenza di san Giovanni Battista, per essere trasformate in nocino e quelle mature rastrellate in autunno da mangiare fresche dopo averle spellate con cura, ma anche usate per ricette dolci e salate, del grano da portare al mulino un po’ alla volta per farne farina da conservare in sacchi di iuta al buio e al fresco di cantina.
Avevamo-allora- anche un allevamento di conigli che soddisfaceva il bisogno settimanale di proteine, perché il consumo di carne di altre specie animali era un lusso riservato solo alla domenica ed alle altre feste in rosso sul calendario. Andare a fare l’erba per i conigli era un’azione quotidiana demandata alle mie due sorelle maggiori, in un pezzo di terreno che confinava per buona parte con la strada poderale, dove cresceva la lupinella, pianta dai fiori bellissimi con sfumature dal rosa fucsia al violetto. Io spesso avevo il permesso di accompagnarle, ma non di falciare l’erba. Mi divertivo ad osservare le loro schiene curve al calar del giorno, quando la calura estiva cedeva il passo alla frescura serale, ma anche a correre nel prato e a rotolarmi nell’erba ad osservare gli animaletti che lo abitavano. Il terreno era in pendenza e, nella parte più alta, c’era un boschetto di querce tra le rocce che era la mia passione, dove, nei bei pomeriggi di primavera, andavo con la famiglia alla ricerca di asparagi selvatici. In verità, mi attiravano di più i fiori spontanei, che facevano capolino tra le rocce, soffocati nell’ erba o sotto cespugli pungenti di rovi e pungitopi. Di narcisi e ciclamini spontanei , insieme a pratoline e violette, ne potevo cogliere a volontà, saltellando tra ombra e luce per farne mazzetti per i miei riccioli biondi o da regalare l’indomani alla maestra. Molto più prosaicamente gli altri, arrampicandosi per più sentieri impervi e scoscesi, portavano a casa un ingrediente prelibato da cucinare in vari modi.
In questo pezzo di terra di quasi un ettaro, non poteva mancare la produzione di legumi, soprattutto ceci e fagioli, la cosiddetta carne dei poveri, che sostituiva per almeno due volte a settimana il consumo di carne, per le loro proprietà nutritive simili alle proteine animali. La pancia piena della pignatta, vicina al fuoco acceso, era una presenza rassicurante e la compagna dei lunghi pomeriggi invernali di tutti noi. Il giorno dopo il pane duro accoglieva in un accattivante connubio, i fagioli caldi nel piatto e l’olio versato a filo sprigionava una sinfonia di sapori e di fragranze indescrivibili.
Tutto era rigorosamente prodotto in casa. Tutto era noto. Tutto era nostro. Nessuno spreco. Si trattava di un’economia quasi del tutto autosufficiente, che già allora riusciva ad utilizzare i propri rifiuti come risorsa La raccolta differenziata era di là da venire, ma noi differenziavamo ogni cosa quasi senza accorgercene: la carta si smaltiva nel camino, i rifiuti organici venivano gettati in una fossa appositamente scavata nel terreno, nel luogo più nascosto alla vista e distante dalla casa che, assieme al letame prodotto dall’allevamento dei conigli, si trasformava presto in concime naturale per le future coltivazioni.
E le piantine, da orto e da giardino, non si compravano mica al vivaio o dal fioraio! Ogni famiglia aveva il suo semenzaio: si conservavano con cura i semi dell’anno precedente e si scambiavano con parenti e vicini quelli più produttivi. Quando vedevo mia madre gironzolare vicino a fiori e cespugli, credevo quasi che li accarezzasse ed invece, semplicemente, andava alla ricerca dei semi, che poi custodiva gelosamente in barattoli di latta fino al tempo della stagione futura.
L’abbigliamento si riciclava tutto, fino all’usura naturale, passando da figlio a figlio, magari con qualche abile ritocco. I calzini avevano vita lunga, perché andavano rigorosamente rammendati con ago, filo e…..l’uovo di legno, pressocché sconosciuto ai giorni nostri, in cui impazza l’usa-e-getta e dove i prodotti hanno vita breve. Si dice che sia molto più comodo e conveniente, perché non si può perdere tempo.
Sarà! Però rimpiango la vita semplice e lenta di quegli anni.
Pensate come eravamo strani, allora! Mia madre scambiava oggetti di ferro vecchio arrugginito o anche di rame-così prezioso oggi!- con piccole bacinelle di plastica su proposta di avventori che bussavano al campanello di casa con i loro camion già pieni di questo materiale rivoluzionario. Erano i primi segnali che il mondo stava cambiando, senza chiederci consigli e pareri. Con la plastica arrivò di tutto nelle nostre case, persino i vasi per fiori e piante e finanche fiori e piante finte.
Se, con i vasi di terracotta, dovevamo fare molta attenzione a non farceli cadere dalle mani, altrimenti erano rimproveri a go-go, ramanzine senza fine, tirate di trecce e pianti di pentimento, con la plastica tutto diventò più semplice.
Almeno, così ci sembrò allora.
Oggi ci sta sommergendo e non sappiamo come fare. Tutti dicono che è indispensabile reinventare comportamenti in linea con il pensiero ecologico, che rispettino meglio la natura, per non autoestinguerci. Per noi della vecchia guardia è tutto molto più facile. Siamo nati in un’epoca del ri-uso e sprecare non è stato mai il nostro forte, grazie a chi ci ha educato in tal senso.
Penso ai genitori, alla scuola, alla mensa e al doposcuola, agli amici, ai vicini di casa, all’oratorio….tutti orientati nei fatti al rispetto dell’ambiente e alla sobrietà di vita.
Oggi fare l’orto pare sia molto trend ed ogni spazio, piccolo o grande che sia, va bene; sul terrazzo, nei vasi, in giardino si sperimentano coltivazioni di prodotti semplici ma di grande soddisfazione: pomodori,lattughino, fragole, misticanza ed altro. Lo si fa anche nelle scuole.
Di certo non si potrà fare a meno della spesa dal fruttivendolo, ma è cosa buona esercitarsi per capire quanta fatica e cura costa produrre il cibo dalla terra!
Non potrà bastare, ma è un piccolo passo in avanti. E la vita si vive così. Con piccoli gesti, che diventano grandi, se son tutti a farli.