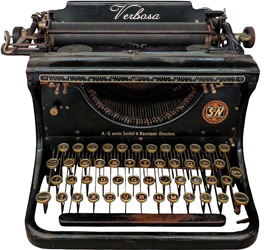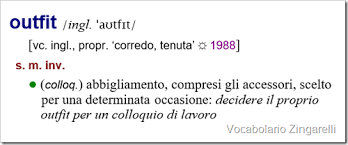Cosa spinge ultrasessantenni a vestirsi come teenagers, a scrollarsi di dosso uno stile sobrio per sposare un abbigliamento più trendy?
Cosa spinge ultrasessantenni a vestirsi come teenagers, a scrollarsi di dosso uno stile sobrio per sposare un abbigliamento più trendy?
E’ un dato di fatto che la nostra è una società che fa riferimento ad immagini-idolo, a modelli e ad icone provenienti soprattutto dal mondo della pubblicità, dello sport, dello spettacolo, della televisione, preconfezionati ad arte, proposti al solo scopo di ingabbiarci in un target, dal quale è preferibile non allontanarsi, per non correre il rischio di sentirsi “out”. Apparendo come gli altri ci sentiamo maggiormente rassicurati, meno soli e, grazie all’autostima che generiamo, addirittura migliori di quanto in realtà siamo. Accettati e legittimati, indossiamo -per convenienza- quella maschera che ci spinge a vivere secondo schemi ben definiti, ben sapendo che, a volte, contrastano con il nostro essere.
Vivendo di relazioni l’apparire diventa una manifestazione necessaria perché l’immagine è la prima cosa che si “spende” nel contatto con l’altro. Il mostrarsi agli altri dovrebbe essere lo specchio dell’essere, ma è sempre più un bluff. Sono sotto gli occhi di tutti le vite finte, apparenti, esteriori, chiamate ad interpretare ruoli inadatti e insostenibili nel tempo, nella convinzione che quel modo di apparire sia sinonimo di successo. Siamo controfigure che sgomitano per ritagliarsi un ruolo da protagonista sul palcoscenico della vita e proviamo ad interpretare anche parti non congeniali, con look esagerati e ridicoli, nell’auspicio di poter essere ammirati ed invidiati. L’apparire è perfetto se combacia con l’esaltazione della propria personalità, perciò deve corrispondere davvero a chi siamo. In caso contrario, rimaniamo comparse. Non solo. La finzione, se tirata per le lunghe, può rivelarsi faticosa, frustrante e persino alienante.
La vulnerabilità è la fragilità del nostro tempo. Una volta prerogativa solo di un’età, oggi possiamo dire che siamo tutti “adolescenti”, avvolti da una confusione esistenziale, senza più paradigmi di riferimento. E sulla consapevolezza di ciò che vogliamo essere c’è molto da fare, a qualsiasi età. Il filosofo Emmanuel Kant distingue tra due categorie di entità: le cose e gli esseri umani. Le prime hanno un prezzo, un valore strumentale, d’uso e di scambio. Gli esseri umani non hanno prezzo, ma solo dignità, un valore intrinseco, una variabile indipendente da qualsiasi immagine specifica o da aspettative predeterminate. La società in cui viviamo spinge a salvaguardare il pregiudizio della modellizzazione “dover essere al passo coi tempi”, per cui non riusciamo ad accogliere gli altri per ciò che sono, ma soltanto per quel che hanno addosso.
Sarebbe invece molto più importante imparare a convivere con l’assenza, con ciò che non si è e che non si ha, e sviluppare contezza del fatto che il proprio valore è sempre lo stesso anche se manca qualcosa. Sin da bambini siamo chiamati a fare i conti con l’immagine di sé che gli altri hanno nei nostri confronti. E’ certamente un’immagine ideale, che genera aspettative e frustrazioni tali da rendere difficile l’intima convivenza con i propri vuoti e le proprie mancanze. Quando ciò accade, si cerca di colmare questi spazi con un’immagine comprata a poco prezzo e già pronta all’uso. Per questo motivo, entriamo in mutande in un atelier e ne usciamo con il migliore abito che potessimo sperare di comprare. Il sarto ce lo ha cucito addosso, senza sbavature o difetti. Un outfit perfetto, ma siamo sicuri che era proprio quello di cui avevamo bisogno?