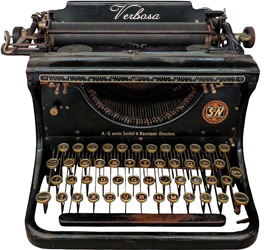Avvicinarsi al cibo sembra solo un’esigenza fisica di sopravvivenza, perché nutrirsi è un atto quasi istintivo che diamo per scontato nel momento in cui avvertiamo il senso di fame o di sete.
Invece tralasciamo di considerare che il mangiare racchiude in sé una complessa struttura di significati, che rimanda ad una visione olistica del mondo, si coniuga con il rispetto dell’ambiente che ci ospita ed assume un alto valore psicologico e sociale, quando si lega alla nostra storia familiare ed alla cultura di appartenenza.
La cultura dello stare a tavola è antica e si tramanda di generazione in generazione; sa trasformare il convivio in momenti di piacere puro, quando il pensiero corre ai sapori, agli odori, agli aromi, alle fragranze che i cibi sanno emanare e a tutte quelle sensazioni visive, gustative ed olfattive che scatenano la voglia di soddisfarle tutte.
Ho letto da qualche parte di una piramide alimentare che pone alla sua base non gli alimenti di cui si ha più bisogno, ma il piacere della convivialità, dove l’azione del condividere il cibo appare come uno strumento comunicativo indispensabile per stabilire e mantenere rapporti.
E’ sempre più vero che la socialità passa ancora oggi -come un tempo- dal cibo, seppure con modalità e finalità differenti. Non dobbiamo mai dimenticare che il termine “compagno” deriva dal latino cum-pani, ovvero “dividere il pane con”.
L’odierna società dell’opulenza e dell’iperalimentazione, però, ci spinge ad avvicinarci al cibo non solo quando abbiamo fame. Probabilmente come risposta ad un bisogno che tenta di riannodare i nodi sfilacciati della vita sociale, di superare l’ individualismo dominante che ammorba l’ esistenza, di dissolvere la diffidenza e la paura dell’ altro, di contraddire la solitudine e l’ isolamento cui sembriamo condannati dalla vita frenetica di oggi e dalle architetture che abitiamo.
In questo senso, il cibo costruisce e rafforza legami e la convivialità attorno alla tavola diventa un luogo straordinario di umanizzazione, di ascolto reciproco, di scambio della parola, luogo dove dire sì alla vita, se pur tra fatiche ed impegni, alla ricerca di gioie e speranze. L’atto del mangiare produce appagamento sociale e condivisione: si va dai buffet di lavoro ai brevi spuntini tra colleghi per definire obiettivi comuni o rafforzare uno spirito di squadra in previsione di un lavoro più efficace , dai pranzi delle feste di ogni tipo alle serate tra amici per rinsaldare legami di affetto e di solidarietà.
Ma il cibo può segnare anche privazione ed esclusione, a livello macro e micro-sociale. Nel primo caso, le distanze sempre più accentuate tra Nord e Sud del Mondo e le statistiche riguardanti il numero di persone prive del cibo sufficiente ad assicurare il sostentamento sono sempre più agghiaccianti. Nel secondo, il cibo diventa uno strumento che definisce il gruppo e ne marca l’identità collettiva e individuale: se offrire un pezzo della propria merenda è indice di solidarietà e amicizia, escludere dalla condivisione produce diffidenza, separatezza e allontanamento.
Quando l’uso smoderato di cibo si trasforma in vero abuso, si ricorre da un po’ di tempo a diete drastiche per ritrovare immediatamente la forma perduta. Il digiuno come terapia radicale sta assumendo sempre maggiore popolarità nella nostra società, che ci vuole perfetti, armoniosi e scattanti. In questo senso, molti manuali la propongono come la panacea, una pratica semplice ed ecologica, drastica ed efficace.
Anche Gesu’, nella sua breve vita terrena, si sottopose al digiuno e, alla fine, ebbe fame.
Si legge nel Vangelo di Matteo: “Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame”.
Il tempo di Quaresima, che rappresenta il nostro deserto da attraversare, è tappa di avvicinamento e di ritorno al Signore, dove il digiuno diventa fonte di purificazione da tutti gli eccessi, ma soprattutto forma di sperimentazione empatica di ciò che provano coloro che mancano anche del necessario, di attenzione al prossimo, di una vita senza sprechi di cibo e più rispettosa delle risorse del pianeta, che non sono inesauribili.
Se ripensiamo al fatto che sulla Terra 2/3 della popolazione ha fame e 1/3 fa la dieta o il digiuno, dovremmo essere disponibili a sperimentare per tutto l’anno pratiche abituali più sobrie per un rapporto più corretto con il cibo, dove anche il digiuno ha diritto di cittadinanza se non lo utilizziamo solo per recuperare la forma fisica , ma per liberarci dalle scorie di negatività, arroganza, pessimismo, tensioni, amarezza, tristezza, egoismo, malcontento, rabbia, che incameriamo quotidianamente.
A Pasqua poi, seguendo l’invito di Papa Francesco, proviamo anche a digiunare di parole e a riempirci di silenzio per ascoltare gli altri. Sarà davvero una bella dieta disintossicante a costo zero.