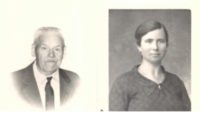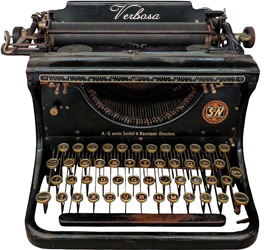Campo d’Antuono é un borgo di case in pietra, dove vivevano molte famiglie dallo stesso cognome di mia madre: i Trosino, tutti tra loro parenti.Anche nonno Cosimo e nonna Maria Grazia portavano lo stesso cognome e pare che fossero cugini I matrimoni tra consanguinei a quei tempi- parlo del 1924- erano frequenti. Mia madre era nata nel 1925 e mio zio Alfredo solo l’anno dopo, perché mio nonno aveva fretta di partire per gli Stati Uniti in cerca di fortuna, ma non voleva lasciare da sola la moglie! Lei, per molti anni vedova bianca, con le rimesse che, d’oltreoceano, le inviava periodicamente il marito, avrebbe cresciuto dignitosamente i due figli, nell’attesa del suo ritorno. Mio nonno visse molti anni a Boston facendo l’operaio di non so quale ditta, ma so che zio Alfredo potè diplomarsi, studiando da geometra, mentre mia madre non ne volle più sapere, dopo la licenza elementare.
La casa in pietra a due piani con scala esterna per salire alle camere da letto ancora oggi è lì a ricordarci le tracce di un tempo che fu. E, guardandola oggi con il tetto cadente e le finestre sconnesse, con i gradini sgretolati dalle intemperie, desolatamente abbandonata e sola, ripenso alla gioia che provavo quando mamma mi annunciava all’improvviso: –Oggi andiamo a trovare i nonni a Campul’antuon’– Era il 1960, avevo solo 5 anni e, saltellando allegramente sulle mie gambucce esili, mi avviavo a piedi dietro di lei, carica di borse (perché le mamme sono sempre cariche di qualcosa!), sul sentiero battuto che in salita mi portava, dalla nuova casa di via Puglia, alla meta desiderata, attraversando boschi di querce che, quasi soffocati da grovigli di rovi, biancospini, pungitopi, felci, agrifogli asparagi, ciclamini, svettavano verso il cielo con i loro tronchi robusti e le loro chiome rigogliose in estate e con i rami desolatamente nudi nel gelido inverno. A quel tempo, li disegnavo con braccia, faccia e gambe nei miei primi tentativi di rappresentazione del mondo, con la voglia di dare un’anima alle cose che incontravo, mediante il gioco simbolico e fantastico, tipico dell’infanzia. Al culmine della salita, prima di girare a destra, ritrovavo la scuola rurale, un modesto edificio a piano terra, che era stato frequentato da mia madre e, nei primi due anni di scolarità, anche dalle mie due sorelle. Un muretto di pietra viva sulla destra era lì a delimitare confini di proprietà, ma principalmente era il luogo in cui “ritrovarsi”. A qualsiasi ora giungessimo, venivamo accolte da un crocchio di persone impegnate a dialogare tra loro, sedute sotto un grandioso albero di gelsi, su sedili di fortuna, sgabelli a tre piedi di legno o sedie impagliate. Per lo più si trattava di donne che rimagliavano abiti usurati, sferruzzavano con mani abili o pulivano verdure spontanee appena raccolte e persone anziane, con il mento poggiato su un cuscino di mani ruvide, che sostenevano un bastone di legno ricurvo. Raccontavano storie di vita vissuta, aneddoti, strofe in rima, detti sul tempo e sul duro lavoro nei campi. Ed io, accovacciata sul muretto, li ascoltavo affascinata, mentre mi perdevo nei miei pensieri di bambina. Si respirava l’aria della comunità grazie alla disponibilità a condividere quel poco che si aveva: il pane appena sfornato, la pizza e i taralli, la frutta spontanea ed abbondante, raccolta nel paniere col manico. Il ritorno a casa prima dell’imbrunire era una notizia difficile da digerire, se avevo avuto la fortuna di incontrare qualche coetaneo con cui giocare. Allora, il borgo era abitato da tante famiglie che, col trascorrere degli anni, sono andati in cerca di fortuna altrove. Mio nonno Cosimo, sempre un po’ taciturno, amava stare in disparte; lo si poteva trovare davanti alla cantina, dove un sedile in pietra veniva baciato dal gradevole sole primaverile o dall’ombra pomeridiana nelle giornate più calde. Me lo ricordo sempre assorto nel suo lavoro solingo, mentre con un bastone percuoteva il raccolto di ceci o certosinamente sgranava il mais nel cripo, mettendo ordinatamente da parte le foglie, per farne materassi.
La cantina, con i muri di pietra viva ed il tetto spiovente dalle travi in legno era di fronte alla casa, separata da un tratto di strada brecciata. Sul lato posteriore, quello verso il costone, c’era una sorta di tettoia sotto la quale venivano riparate le messi e, più oltre, all’aperto, c’erano il pollaio e la conigliera.
L’interno della cantina era un vero e proprio luogo magico: vi entravo e potevo sfogare la mia fantasia, perché una sola finestrella, che non riusciva a mettere in fuga il buio, lasciava intravedere solo i contorni delle cose. Poteva accadere che la mia presenza umana riuscisse a rompere gli equilibri del posto, smuovendo topini e insetti. In quel caso, indietreggiavo per la paura e, magari inciampando in una pietra sconnessa del pavimento, potevo ritrovarmi a terra, sotto le ceste ed le grate che nonna Maria Grazia utilizzava per seccare i pomodori d’estate o le zucchine da conservare sott’aceto.
La vendemmia ad ottobre era un rito a cui non si poteva mancare: tutti a raccolta nei filari ordinati per tagliare l’uva e riporla nei cesti. Mio fratello dava una mano a portare i cesti sulla strada, dove attendeva in paziente attesa un carro, agganciato ad un trattore, ma prima ancora da un animale.
Ma il momento più bello era sempre in cantina, dove l’uva veniva prima versata nella macina per un primo trattamento e poi nel torchio di legno per la spremitura. Un odore acre e gradevole ti arrivava alle narici a caratterizzare un momento importante della stagionalità. Mio nonno, nei giorni successivi era alle prese con il torchio, che spingeva con tutte le sue forze e noi ad aspettare l’uscita del primo vino spumeggiante, raccolto con un bicchiere di fortuna, pronti ad assaporarlo nella sua dolcezza immatura. Si produceva il vino per la famiglia, che doveva bastare per tutto l’anno, ospitato e protetto in damigiane verdi impagliate fino a metà, in fiaschi di varia grandezza, in bottiglioni di vetro scuro che non lasciavano intravedere il contenuto. Quelli erano giorni di festa, che culminavano con il “cap’canal’”, il pranzo finale, che chiudeva la vendemmia, preparato dalla nonna, a base di maccheroni al sugo, padelle di verdure e patate fritte sul camino o sulla fornacella, rivestita di maioliche bianche e blu ed alimentata a legna, la braciola di vitello, la torta classica fatta di pan di spagna, crema gialla e cioccolata.
La casa dei nonni era più che spartana: al piano terra si accedeva dalla porta d’ingresso direttamente nella cucina: aveva i portelloni che si staccavano per dare luce di giorno ed osservare quello che succedeva fuori; sulla parete a sinistra un lavandino senza acqua corrente, il tavolo addossato al muro, poi il focolare domestico, di fronte alla porta sulla sinistra la fornacella e, a seguire, il forno a legna, sulla parete destra una insenatura nel muro custodiva una cristalliera incassata con le poche suppellettili d’uso comune, che interrompeva le sue funzioni ad altezza d’uomo, dove un incavo libero ospitava una radio in radica, unico segno dei favolosi anni ’60, che stavano distribuendo progresso e benessere. La stanza adiacente era adibita a deposito: tanti sacchi di iuta contenevano grano, un orcio in pietra scalpellinata custodiva l’olio; varie tavole di legno massiccio su cui ordinare cose all’occorrenza, tra cui-all’incirca ogni quindici giorni- poggiare la “fazzatora”, per “ammassare” il pane. Tanti contenitori di terracotta gialla con doppi manici per i peperoni sott’aceto, altri senza e di color avorio pieni di sugna, avevano il compito di conservare ogni tipo di salami. Al soffitto tanti ganci per appendere ogni ben di Dio che il maiale produceva, una volta allevato ed trasformato in alimenti nel periodo più freddo dell’ inverno. Al piano superiore si accedeva tramite una scala esterna, direttamente nella camera dove dormivano mia madre e lo zio Alfredo; a sinistra la credenza che conteneva le suppellettili più importanti, che oggi fa bella mostra di sé nella casa di Ada, poi sulla destra, addossata alla finestra la macchina per cucire Singer, toccata in eredità a me, insieme al bel comò della camera dei nonni, commissionato ad un artigiano del posto agli inizi del secolo. Non so come ci si riscaldasse in queste camere, ma posso immaginare il gelo di quando ci si metteva a letto la sera. Ho un vago ricordo di mattoni riscaldati davanti al camino, accanto alla pignata che cuoceva legumi senza altri sprechi di combustibili, che rilasciavano tepore a lungo se avvolti in pezze di lana.
Quando arrivavamo dai nonni, era d’abitudine andare a fare rifornimento d’acqua al pozzo, che si trovava in un appezzamento di terreno poco distante da casa, dove si coltivava l’orto di casa, al cui centro faceva bella mostra di sé una pianta di sorbe. Sentivo spesso il nonno ripetere “col tempo e con la paglia maturano le sorbe“. Allora non capivo cosa volesse dire. In realtà, imparai a mie spese che le sorbole non potevano essere mangiate appena colte allorchè, addentandole per la prima volta, assaporai un amaro in bocca immediato, tanto da sputarne a terra il composto. Vidi la nonna riporle al buio sulla paglia in cantina per attenderne la maturazione. Sarà per questo motivo che tale pianta è andata persa nel tempo? La cura lenta non si addice più ad una società che vuole consumare in fretta quel che produce?
La Pasqua dai nonni cominciava almeno due settimane prima. Venivamo reclutati tutti ed ognuno aveva il suo compito assegnato. Si cominciava con i taralli, semplici ed all’uovo. C’era chi impastava, chi faceva rotoli che si allungavano sotto le mani e poi si chiudevano con un movimento deciso del pollice, chi li scaldava nell’acqua bollente per qualche minuto, chi li metteva in fila tutti ordinati come soldatini pronti per essere infornati. Una vera e propria task-force. Poi si procedeva con le pigne di Pasqua, dolci cresciuti simili al panettone, ma non così morbidi, che dovevano lievitare 48 ore prima di essere infornati e che quando li mangiavi ti restavano in gola se non bevevi qualcosa. La glassa di copertura era fatta con albume d’uovo montato a neve con lo zucchero e i confettini di tutti i colori. Qualche giorno prima di Pasqua, si lavorava bene il grano, lo si cuoceva a dovere per le pastiere, che venivano preparate anche con il riso. E poi….la pizza chiena, dove potevi trovarci di tutto, salami formaggi uova e..tanto altro! Ma non si poteva toccare fino alla Pasquetta, augurandoci che il tempo bello ci avrebbe consentito, distesi sulle coperte di erba giovane e pratoline, di gustarla in tutta la sua bontà.
Tutto ciò finisce nel 1969, il 31 dicembre, quando nonna Maria Grazia, ammalata di diabete, muore a 70 anni (era nata il 1° luglio del 1899).
Il portone della casa si chiuse definitivamente, lasciandovi all’interno-gelosamente custoditi- tutti i più bei ricordi di quegli anni. Mio nonno, rimasto solo, subito dopo si trasferì nella nostra casa in via Puglia, dove visse tutti i suoi restanti anni fino al 23 gennaio 1977. Aveva 86 anni non ancora compiuti (era nato il 6 aprile 1891).